1 novembre – “Luminație”, la Festa della Luce
Mia nonna diceva sempre che non puoi sentire di appartenere veramente a un posto se non hai i tuoi morti vicino e se non puoi andare ad accendere una candela sulla loro tomba il 1 novembre. E’ il giorno in cui in Romania si celebra la Festa dei morti, chiamata anche Luminație, ossia la Festa della Luce. Nel cimitero del paese dove viveva non riposava nessuno dei suoi. I miei nonni erano rifugiati di guerra, sono stati costretti a fuggire dall’Ucraina (all’epoca apparteneva alla Romania), nel febbraio del 1944, dopo l’occupazione sovietica, in carrozza, con una bambina appena nata (mia mamma), hanno attraversato buona parte della Romania, vivendo un po’ dovunque, per poi stabilirsi infine a Mintiu, paese natale di mio nonno, nel cuore della Transilvania. Un villaggio di 400 anime, troppo piccolo e troppo lontano da tutto quello che mia nonna aveva lasciato in Ucraina, prima di scappare via. Fratelli, sorelle, genitori, amici… tutto svanito in quella notte del ’44. Per 30 anni non ci è mai potuta tornare per motivi politici, 30 anni di ricordi che la legavano irrimediabilmente alla sua terra, a migliaia di chilometri di distanza. Il regime comunista aveva deciso di tagliare ogni filo che univa le famiglie separate dalla guerra e dagli accordi cinici con i quali le grandi poteri si divisero l’Europa alla fine della seconda guerra mondiale. Non potendo prendersela con la storia, che spesso non lascia scampo, se l’è presa per tutta la vita con mio nonno, “colpevole” di averla amato e di averla portata via e, chissà, forse di averla salvata.
In 30 anni aveva perso tutto della sua vita precedente, tanti amici e parenti da non avere più la forza di contarli. Lontani in vita e lontani anche dopo la morte. E così mia nonna, per una sorta di protesta silenziosa contro le proprie avversità, non andava mai al cimitero del suo paese, nemmeno per accompagnare mio nonno, che, invece, aveva i suoi genitori e altri parenti seppelliti lì. Piuttosto si chiedeva spesso dove fossero stati sepolti i suoi cari, in quale terra, sotto quale bandiera.
Profira, mia nonna, conduceva così la sua vita, cresceva i propri figli, i nipoti, me, coltivava il suo orto, amava suo marito, si arrabbiava a volte con la Vita e spesso anche con la Morte. Poi arrivava novembre, e solo in quei giorni capivo quanto sofferente potesse essere la vita di questa donna contesa tra l’amore di essere madre e il dolore di essere figlia senza famiglia.

Nel paese c’era un vero rituale che tutti seguivamo: si andava al cimitero per preparare le tombe, a tagliare l’erba, pulivamo tutto intorno, piantavamo tanti crisantemi colorati. Passavamo giornate intere a curare quel posto, sulla piccola collina, alle spalle della chiesa, in mezzo ad un frutteto. In primavera era un tripudio di fiori bianchi e rosa che finivano poi a terra in un enorme tappeto colorato che avvolgeva come in un abbraccio le croci. Andavamo al cimitero anche noi, i bambini, era l’occasione per stare insieme e partecipare, a modo nostro, ai preparativi della festa. Conoscevamo a memoria tutte le lapidi, i nomi incisi sulle croci, sceglievamo quali erano le più belle e ci piaceva guardare le foto sulle croci, di quelli che non c’erano più e di quelli che erano ancora vivi, ma avevano provveduto, da tradizione, ad organizzarsi per la dipartita.
Era tutto così naturale, la morte non ci spaventava, anche perché crescevamo in un tempo scandito dall’alternarsi dalle stagioni, e, soprattutto, dai grandi eventi della vita del piccolo paese: nascite, battesimi, matrimoni e funerali. Era un mondo essenziale e semplice, in cui nessuno pensava che si dovesse nascondere o addolcire una verità cruda come la morte. Eravamo in prima fila ai matrimoni, a saltare, ballare o suonare insieme ai musicisti del paese, a gironzolare intorno alla sposa, mentre la preparavano per il grande giorno, e sempre in prima fila anche ai funerali, a guardare e ed ascoltare affascinati le donne vestite di nero, bocitoare, le cosiddette prefiche (le nostre pero non venivano pagate) quelle che raccontavano, tra un pianto e l’altro, la vita del defunto, come se fosse stato il romanzo più accattivante del mondo. Accompagnavamo il corteo funebre fino al cimitero e nessuno ci allontanava quando la barra veniva calata nella buca e si concludeva la sepoltura. Non mancavamo neanche alla “festa” che seguiva, a cui partecipava tutto il paese, prete incluso, dove si mangiava tanto e si beveva di meno, visto che ad ogni bicchiere alzato si versavano, da tradizione, alcune gocce a terra, per l’anima del defunto.
Quello che mi affascinava di più di tutti i passaggi obbligati del rituale legato alla morte, era la veglia di tre giorni e tre notti, durante la quale gli amici del defunto si davano incessantemente il cambio, giocavano a carte, mangiando, bevendo, raccontando aneddoti su di lui, facendogli compagnia senza lasciarlo mai solo. Nella credenza popolare, se il defunto veniva abbandonato, arrivava nell’oltretomba smarrito e triste. Mi ricordo che guardavo questi uomini seduti intorno alla barra aperta, che giocavano a carte e alzavano spesso un bicchiere di țuică (grappa) e brindavano per l’amico scomparso, piangevano e poi scoppiavano a ridere, mentre ricordavano qualcosa di divertente, e gli sentivo rivolgersi spesso al defunto con le parole “Ti ricordi quando…?”… Mi sembrava tutto così strano ma teneramente allegro.

Mi rendo conto di quanto sia difficile capire un simile rituale per chi è estraneo alla nostra cultura, nella quale il rito funebre è un mix di paganesimo dacico* e di sacro ortodossismo. Non è stato semplice neanche per mio marito quando ha partecipato, qualche anno fa, alla festa dei Morti nel piccolo cimitero di Mintiu, dove è stata infine seppellita mia nonna, mio nonno e altri parenti. Quando abbiamo deciso di andare e di portare anche Matteo, nostro figlio, ha temuto che sarebbe stata un’esperienza troppo impegnativa, dal punto di vista emotivo, per un bambino di 5 anni. Io lo tranquillizzavo e gli ripetevo che la Festa dei Morti non è per niente una commemorazione, ma una celebrazione, ma non era facile spiegare tutto ciò. Si era convinto da solo a breve, quando, una volta arrivato nel cimitero, ha visto il via vai di gente, che si fermava tra le tombe in attesa di visite e visitando a loro volta le tombe degli amici o parenti. La gente si salutava, si abbracciava, molti di quelli che vivevano lontano approfittavano per tornare in paese una volta all’anno, il 1 novembre. E come in una sorta di mercatino rionale, ognuno invitava gli altri a fermarsi davanti alle tombe della propria famiglia, per bere un bicchiere o mangiare un dolcetto, per l’anima dei defunti. Le tombe stesse si animavano, diventando all’occorrenza tavole da pranzo, banconi di un bar, tutto il cimitero si trasformava in un luogo di un’allegra festa conviviale in cui l’elemento predominante era incredibilmente la Vita. Il prete passava tra le tombe e celebrava brevi messe per ricordare quelli che non c’erano più tra di noi. I bambini correvano allegri giocando a nascondino, dietro le croci di pietra, rafforzando ancora di più l’idea che quella giornata era la festa della luce e della vita. Per tutto il giorno, le candele rimanevano accese e al calar della notte il cimitero si trasformava in uno spettacolo incredibile di sconfinate luminarie che animavano la notte fino all’alba successiva. Nessuna croce rimaneva al buio quella notte, perché la luce delle candele accompagnava le anime scese tra noi a ritrovare la strada del ritorno.
—-
*Il modo in cui si celebra in Romania la Festa dei Morti, il I novembre, ricorda inevitabilmente i riti degli antichi daci, gli antenati del popolo rumeno, che credevano nell’immortalità dell’anima e festeggiavano la morte come un passaggio ad una vita migliore, dove li aspettava il loro dio, Zamolxes. I daci ballavano e cantavano quando moriva qualcuno e piangevano quando nasceva un bambino. Con una simile visione sulla morte, si può spiegare anche perché l’unico Cimitero allegro del mondo si trovi in Romania, a Săpânța, un luogo dove si ride in faccia morte e si trasforma in arte un modo a dir poco originale di esorcizzare la morte.
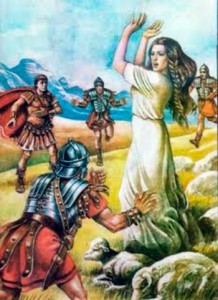 “Così nacque il popolo rumeno”, concludevo, in modo metaforico, la lezione sulla genesi del popolo rumeno. Adesso immaginatevi dei ragazzi di 13-14 anni che, oltre ad essere colpiti dal romanticismo di questo amore impossibile, erano seriamente confusi sul significato di questa leggenda: “Professoressa, non capiamo com’è nato, tecnicamente, il popolo rumeno se, quando Traiano la toccò, Dochia si era trasformata in una statua di pietra!”, queste ed altre simili erano le domande volutamente imbarazzanti. Tra insinuazioni e risate, la loro fantasia era inarrestabile, proprio come quella degli autori anonimi e collettivi di questo mito, tramandato oralmente nel tempo. Spetta alla razionalità e ai trattati di storia fare chiarezza tra tutte le contraddizioni presenti nel racconto mitico. E quello che la storia narra sull’invasione della Dacia ha molto di eroico, ma veramente poco di romantico.
“Così nacque il popolo rumeno”, concludevo, in modo metaforico, la lezione sulla genesi del popolo rumeno. Adesso immaginatevi dei ragazzi di 13-14 anni che, oltre ad essere colpiti dal romanticismo di questo amore impossibile, erano seriamente confusi sul significato di questa leggenda: “Professoressa, non capiamo com’è nato, tecnicamente, il popolo rumeno se, quando Traiano la toccò, Dochia si era trasformata in una statua di pietra!”, queste ed altre simili erano le domande volutamente imbarazzanti. Tra insinuazioni e risate, la loro fantasia era inarrestabile, proprio come quella degli autori anonimi e collettivi di questo mito, tramandato oralmente nel tempo. Spetta alla razionalità e ai trattati di storia fare chiarezza tra tutte le contraddizioni presenti nel racconto mitico. E quello che la storia narra sull’invasione della Dacia ha molto di eroico, ma veramente poco di romantico. , la conquista delle Dacia da parte dei romani, sotto la guida dell’imperatore Traiano, fu un’operazione militare durata cinque anni, che impegnò metà del potenziale bellico dell’impero romano.
, la conquista delle Dacia da parte dei romani, sotto la guida dell’imperatore Traiano, fu un’operazione militare durata cinque anni, che impegnò metà del potenziale bellico dell’impero romano.
 gli fosse conferito un posto d’onore nella storia del grande impero. Ma Traiano fu attratto anche dal grande tesoro di Decebal, soprattutto perché l’Impero era in quegli anni sempre più povero. La Dacia aveva numerose miniere d’oro e argento e rappresentava per i romani un vero El Dorado.
gli fosse conferito un posto d’onore nella storia del grande impero. Ma Traiano fu attratto anche dal grande tesoro di Decebal, soprattutto perché l’Impero era in quegli anni sempre più povero. La Dacia aveva numerose miniere d’oro e argento e rappresentava per i romani un vero El Dorado. Massacri, devastazioni, teste romane su delle picche, romani che incendiano villaggi, daci fatti prigionieri e deportati, accampamenti in luoghi desolati, sconosciuti alle mappe dei soldati, foreste e monti impenetrabili, Traiano che guarda la testa del re Decebal, portata come trofeo da uno dei suoi soldati. Scene di lotta tra i daci e i romani, immagini terribili raffigurate magistralmente sulla Colonna Traiana, alcune portate a nuova fama cinematografica nel famoso film di Ridley Scott, il Gladiatore.
Massacri, devastazioni, teste romane su delle picche, romani che incendiano villaggi, daci fatti prigionieri e deportati, accampamenti in luoghi desolati, sconosciuti alle mappe dei soldati, foreste e monti impenetrabili, Traiano che guarda la testa del re Decebal, portata come trofeo da uno dei suoi soldati. Scene di lotta tra i daci e i romani, immagini terribili raffigurate magistralmente sulla Colonna Traiana, alcune portate a nuova fama cinematografica nel famoso film di Ridley Scott, il Gladiatore. an Pietro apre le porte del Paradiso. Sono pochi quelli destinati alla dannazione, l’artista conferendo molto spazio alla resurrezione e all’entrata nel Paradiso. La maestosa composizione, di grande ricchezza creativa, è rappresentata su un fondo azzurro, intenso, nelle sue infinite tonalità.
an Pietro apre le porte del Paradiso. Sono pochi quelli destinati alla dannazione, l’artista conferendo molto spazio alla resurrezione e all’entrata nel Paradiso. La maestosa composizione, di grande ricchezza creativa, è rappresentata su un fondo azzurro, intenso, nelle sue infinite tonalità. dicata, negli ultimi anni, al restauro dei dipinti, “è proprio il colore che ha portato le anime tra queste mura, un vero miracolo della fede. Ogni santo raffigurato, ogni storia biblica, ogni dettaglio si sono fissati negli occhi dei visitatori grazie all’azzurro…E’ una carezza che giunge dal cielo…”
dicata, negli ultimi anni, al restauro dei dipinti, “è proprio il colore che ha portato le anime tra queste mura, un vero miracolo della fede. Ogni santo raffigurato, ogni storia biblica, ogni dettaglio si sono fissati negli occhi dei visitatori grazie all’azzurro…E’ una carezza che giunge dal cielo…” “atleta di Cristo e un vero difensore della fede cristiana”. Si susseguirono tante altre battaglie e solo nel 1488, il voivoda mantenne la promessa fatta al sua consigliere-eremita e ordinò la costruzione di un monastero a Voroneț, che doveva diventare un luogo sacro simbolico in quella parte dell’Europa cristiana minacciata in permanenza dai turchi. Il monastero fu edificato in meno di 4 mesi, ma gli affreschi furono aggiunti 60 anni dopo. Voroneț fu solo uno di una lunga lista che contiene tanti luoghi di culto costruiti da Stefano il Grande, nei suoi 44 anni di principato: la tradizione vuole che ci fosse stata una chiesa per ogni anno e per ogni battaglia vinta contro i turchi. Le malelingue, esperte in “gossip storico”, parlano anche di tanti figli del voivoda, legittimi e illegittimi, certo, non tanti quanti i luoghi sacri che ha fatto edificare. Ma queste “chiacchiere da salotto” non hanno impedito la Chiesa Ortodossa a santificarlo, nel 1992, per il suo ruolo fondamentale nella difesa della cristianità. Nel 1475, Stefano il Grande scrisse una lettera a tutti i sovrani cristiani d’Europa in cui ribadiva che “i
“atleta di Cristo e un vero difensore della fede cristiana”. Si susseguirono tante altre battaglie e solo nel 1488, il voivoda mantenne la promessa fatta al sua consigliere-eremita e ordinò la costruzione di un monastero a Voroneț, che doveva diventare un luogo sacro simbolico in quella parte dell’Europa cristiana minacciata in permanenza dai turchi. Il monastero fu edificato in meno di 4 mesi, ma gli affreschi furono aggiunti 60 anni dopo. Voroneț fu solo uno di una lunga lista che contiene tanti luoghi di culto costruiti da Stefano il Grande, nei suoi 44 anni di principato: la tradizione vuole che ci fosse stata una chiesa per ogni anno e per ogni battaglia vinta contro i turchi. Le malelingue, esperte in “gossip storico”, parlano anche di tanti figli del voivoda, legittimi e illegittimi, certo, non tanti quanti i luoghi sacri che ha fatto edificare. Ma queste “chiacchiere da salotto” non hanno impedito la Chiesa Ortodossa a santificarlo, nel 1992, per il suo ruolo fondamentale nella difesa della cristianità. Nel 1475, Stefano il Grande scrisse una lettera a tutti i sovrani cristiani d’Europa in cui ribadiva che “i